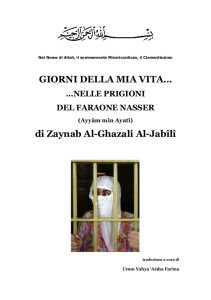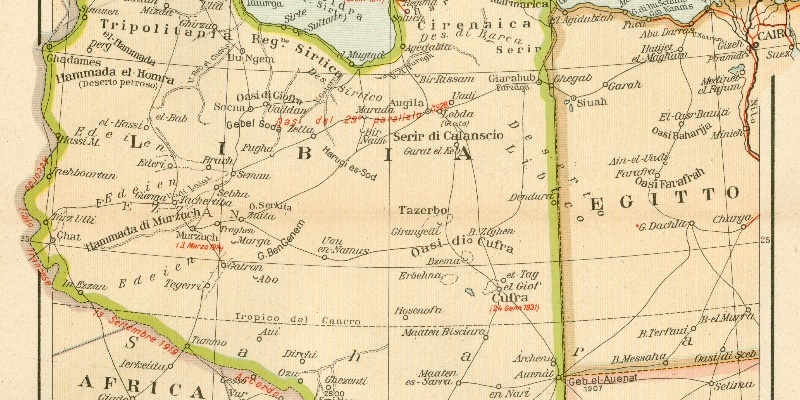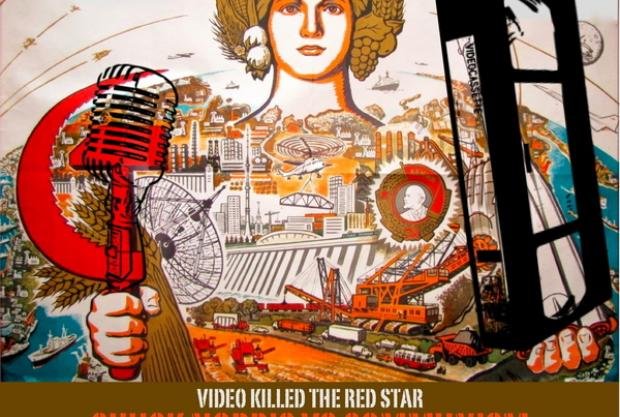pubblicato l’1 marzo 2023 sul n. 60 della rivista periodica Dialoghi Mediterranei dell’Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-lunga-strada-dei-balcani/
Comitato di Redazione1 marzo 2023
di Eugenia Parodi Giusino
Con due semplici concetti Oliver Jens Schmitt, autore del recente libro I Balcani nel Novecento. Una storia post imperiale (Il Mulino, 2021), ci introduce allo studio di una realtà molto complessa e vicina a noi, una storia di aggregazioni e disarticolazioni post-imperiali ed aggiunge così, indirettamente, alcune chiavi interpretative al fenomeno più drammatico di questo secolo in Europa, il conflitto russo-ucraino e l’invasione russa. Questo assunto è uno dei due punti di partenza per provare a spiegare più di un secolo di guerre, deportazioni di massa e lager, modifica dei confini, persecuzione di civili, conversioni forzate avvenute nella penisola balcanica. L’altro è il concetto di “Stato composito”, che significa eterogeneità strutturale degli Stati premoderni e fa riferimento al fatto che gli Stati postimperiali si componevano di territori appartenenti a più Imperi, con i conseguenti problemi di integrazione.
La scomparsa degli Imperi non significa che sia svanita la loro eredità
Scrive l’autore svizzero:
«Tutti gli Stati balcanici erano nati dal collasso di almeno un impero, alcuni da due o più…La scomparsa degli imperi significa effettivamente che, fra il 1918 e il 1923, abbia avuto inizio qualcosa di fondamentalmente nuovo? La storia postimperiale dei Balcani è in grande misura una storia di violenza…questo libro mostra come gli Stati nazionali, in due decenni di guerra (1912-1923, 1930-1949), con un breve periodo interbellico, e poi sotto i diversi regimi comunisti, abbiano inteso livellare e rendere omogenee società multietniche e plurireligiose».
Se, come dice più avanti, «Le guerre balcaniche furono una prova e i prodromi del primo conflitto mondiale», ripercorrere alcune delle successive vicende di questi Paesi, caratterizzate da rivendicazioni etnico-territoriali, può essere molto utile per decifrare comportamenti e politiche aggressive dell’oggi, anche in altre zone europee; qualche preoccupazione, anche se si tratta di fenomeni marginali, hanno destato negli anni scorsi i legami provenienti da elementi di aree balcaniche (Albania, Bosnia, Montenegro, Macedonia, Kosovo, Serbia) con ambienti della criminalità organizzata. Si parla di regioni, territori, popolazioni, lingue da cui, negli ultimi decenni, sono nati Stati e Repubbliche “nuove”, che vanno radiografati mettendo sempre in corrispondenza la loro storia con quella degli Imperi di cui facevano parte sino a fine ‘800, con i nuovi equilibri post bellici (compresa l’influenza determinante dell’Urss), e naturalmente con il dissolvimento della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia nel 1992.
Soltanto nell’impero austroungarico si parlavano una dozzina di lingue e vivevano insieme polacchi, ungheresi, italiani e altre decine di comunità, tutti sottomessi a Vienna cui pagavano le tasse. Le contese per i confini e altre questioni si sono protratte sino ad anni recenti sotto forma diplomatica, come nel caso della Macedonia e della Grecia. Per fare un esempio, quest’ultima ha insistito presso la Comunità Europea perché il nome della ex Repubblica jugoslava della Macedonia, che nel 2004 aveva richiesto l’ammissione nella UE, fosse modificato in Macedonia del Nord. Intanto si cerca di trovare condizioni di vita migliori anche emigrando. Un gruppo di macedoni che lavorano come braccianti nei vigneti delle Langhe hanno festeggiato la loro Epifania ortodossa – scrive la giornalista Federica Cravero su Repubblica del 20 gennaio scorso – tuffandosi nel Tanaro! I primi sono arrivati trenta anni fa, oggi si sono integrati bene.

Confini e tensioni
L’impero turco comprendeva nella penisola balcanica Serbia Bosnia-Erzegovina Montenegro Bulgaria Macedonia Dobrugia (oggi spartita tra Romania e Bulgaria) Albania e la Romania meridionale, mentre la Romania del nord e la Bessarabia (odierna Repubblica moldava) erano indipendenti dal 1878. La Grecia conquista l’indipendenza dal 1830, dopo la guerra di indipendenza greca (50 mila caduti), liberandosi dopo quasi quattro secoli dall’assoggettamento turco e dovendo però accettare una restrizione del limes settentrionale. Assieme a “nazionalismo” ed “autonomia” questa parola, limes,è uno dei termini che monopolizza qualunque narrazione si voglia fare di queste vicende, posto che il significato militare della parola non ha perso di senso, come mostra purtroppo l’attuale guerra. Ma un peso enorme ebbe anche la questione islamica, in una regione dove era presente una pluralità di religioni unica in Europa. Secondo Schmitt (2021: 298) «Per gli stati postimperiali nessun legato degli Imperi fu complicato come la questione islamica». A questo proposito si deve tener conto anche degli allineamenti politici, non uguali per tutti i Paesi, della potente chiesa greco-ortodossa, in aperto dissidio con la chiesa greco-cattolica, denominata Chiesa uniate perché in comunione con la chiesa cattolica di Roma. Un accordo tra la chiesa greca e quella latina, infatti, era durato molto poco, appena quindici anni.
In aggiunta alle forti tensioni tra credi religiosi diversi, tutti gli Stati e le aggregazioni post belliche, ebbero come punto di riferimento e come presenza ingombrante i rapporti, le tensioni, la dipendenza di tipo economico e ideologico dall’Unione Sovietica. Oggi l’impatto dell’invasione russa all’Ucraina nei Balcani occidentali è ingente e condiziona l’iter di adesione di questi paesi alla Unione Europea. In una relazione del 2022 dell’Osservatorio di Politica Internazionale del Governo Italiano [1] Sabina De Silva enumera almeno tre fenomeni influenti: l’adesione alle sanzioni europee verso la Russia cui questi Paesi, tranne la Serbia, hanno aderito, il pericolo riguardante la stabilità e la tenuta democratica delle Repubbliche e il fenomeno migratorio delle rotte balcaniche, peraltro preesistente.
Una stabilità effimera?
Ma perché i Balcani rivestono tuttora importanza per la sicurezza dell’Europa occidentale? Con l’auspicio che sia solo una ipotesi, accenniamo al parere dell’analista geopolitico Daniele Santoro, il quale nel saggio I Balcani sono una bomba a orologeria, si spinge a prefigurare una nuova destabilizzazione in particolare in Bosnia-Erzegovina a causa delle tensioni sociali, e nel Kosovo, caratterizzata da contrasti tra kosovari e serbi, e dove l’Italia ( nell’ambito della missione Nato Kfor) contribuisce al mantenimento di un “ambiente stabile e sicuro” con un forte contingente tra militari, intelligence, team di monitoraggio. Missione che opera anche in altri paesi balcanici. Nell’articolo si sottolinea una crescente influenza nei Balcani occidentali, Serbia compresa, della Repubblica di Turchia, la quale avrebbe avuto un progetto di confederazione imperiale. Ipotesi, questa, che appare realistica se si potrebbero avere le mosse diplomatico-politiche messe in atto in questi anni dal presidente Erdoǧan nel Mediterraneo orientale e quelle aggressive nei confronti della regione del Rojava.
Per avere un’idea dell’attualità di questi giovani Stati e della loro fragilità occorre tornare indietro nel tempo, quanto meno ai primi decenni del secolo scorso. Le tensioni già presenti nei Balcani, principalmente tra Serbia e Impero austroungarico, vengono acuite dall’annessione della Bosnia all’Impero (1908) ‒ dopo tre secoli di dominazione turca e 30 anni di protettorato asburgico – , dalle politiche di controllo della zona da parte zarista e dalla creazione di uno Stato albanese ad opera degli Asburgo, a seguito della prima guerra balcanica contro l’Impero turco (1912-13). Gli accordi di pace a Londra ea Bucarest lasciarono domande in sospeso
Stati ultranazionalisti ostili alle minoranze
Parallelamente al conflitto mondiale e in concomitanza con la crisi in Austria-Ungheria che porta l’Ungheria a dichiararsi indipendente nel 1918, nel 1917 nasce il progetto di un Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Furono cooptati a far parte della “Grande Serbia” il Regno di Montenegro e la Bosnia, dove ricchi proprietari terrieri musulmani costituivano il principale gruppo etnico-religioso, con molti privilegi rispetto ai serbi (in maggioranza cristiani ortodossi) e croati (in maggioranza cristiani cattolici ). A queste radicali trasformazioni, promosse dalla volontà di Gran Bretagna e Stati Uniti per depotenziare l’Impero degli Asburgo, si aggiungono le aspirazioni territoriali di Russia, Bulgaria, Romania, Grecia. Altri due elementi da sottolineare sono la paura diffusa del bolscevismo e le aspirazioni di predominio di Belgrado, corroborata dalla conquista del nord della Macedonia (Vardar), parte del Sangiaccato e la maggior parte del Kosovo. L’ideale di una Grande Serbia e la disomogenea composizione sociale bosniaca sono temi di grande importanza per la genesi della sanguinosa guerra durata dal 1992 al 1995 in Bosnia. Il Regno serbo-croato-sloveno, una “monarchia ereditaria democratica” diventerà Regno di Jugoslavia nel 1929, sino all’invasione tedesca del 1941, e sebbene teoricamente stabilisse equità tra tutte le sue componenti, di fatto la Serbia dominava l’amministrazione ed era detentore del potere. Iniziano in questa fase conversioni forzate al Cristianesimo ortodosso di cattolici e musulmani in Kosovo, diversità di trattamento verso musulmani non slavi, cioè albanesi e turchi, esodo di popolazione, violenze e deportazioni sporadiche che riguardarono i “turchi” (cioè i musulmani) dei Balcani, mentre la Sublime Porta agì violentemente verso i Greci e gli Armeni della zona sud-orientale della penisola (la storica Tracia). Da rimarcare che il Governo di Erdogan ancora si rifiuta di riconoscere il genocidio armeno.
Finita la “Grande Guerra”, oltre al potente Regno di Serbia- Croazia-Slovenia, si definisce una Grande Romania rimpinguata dalla Transilvania, Bessarabia (oggi divisa tra Ucraina e Moldavia), la regione storica della Dobrugia e Bucovina. Quest’ultima fu poi conquistata con la forza dall’Unione Sovietica che compì violenze sulle truppe rumene e sulla popolazione contadina che tentava di raggiungere la Romania. Si configurano così due grandi entità politiche necessariamente multietniche ‒ per sintetizzare il corposo studio di Schmitt (2021) – e apertamente ostili alle minoranze; si sommano problemi dovuti all’unificazione monetaria e fiscale, disomogeneità anche negli eserciti, disordini nelle amministrazioni con aggiunta di corruzione e stabilizzazione di polizie violente. In questa fase, mentre la popolazione contadina subisce la mobilitazione per la guerra e gli sradicamenti dai territori e vive un generale impoverimento, nasce il fascismo rumeno con milizie antisemite e la complicità della autoritaria Chiesa ortodossa, il movimento clerico-fascista ustàscia in Croazia, società segrete militari e parastatali , azioni terroristiche. La Grecia, dove si susseguono golpe e controgolpe, e la Bulgaria sono definiti “Stati pretoriani”, ma tutti i Paesi balcanici tra le due guerre furono Stati di polizia ultranazionalisti, con il conseguente proliferare di Servizi Segreti e spionaggio. società militari segrete e parastatali, azioni terroristiche. La Grecia, dove si susseguono golpe e controgolpe, e la Bulgaria sono definiti “Stati pretoriani”, ma tutti i Paesi balcanici tra le due guerre furono Stati di polizia ultranazionalisti, con il conseguente proliferare di Servizi Segreti e spionaggio. società militari segrete e parastatali, azioni terroristiche. La Grecia, dove si susseguono golpe e controgolpe, e la Bulgaria sono definiti “Stati pretoriani”, ma tutti i Paesi balcanici tra le due guerre furono Stati di polizia ultranazionalisti, con il conseguente proliferare di Servizi Segreti e spionaggio.
Sovvertimenti bellici e stragi
Il fragile assetto prebellico con le due entità maggioritarie, Romania e Regno di Jugoslavia, viene scardinato dalla Seconda Guerra Mondiale mentre le tensioni si trasformano in guerre civili più o meno violente. La Grecia viene economicamente destabilizzata dalla guerra e si delinea una separazione tra zone comuniste e non. Durante le operazioni belliche le alleanze di alcuni Stati con la Germania si fanno e si disfano (Bulgaria, Romania), l’Italia, cambiando fronte, acuisce il vuoto politico. Intere comunità vengono uccise o deportate mentre i nuovi confini dei Balcani sono a dir poco controversi. L’Erzegovina è teatro di violenze sulla popolazione musulmana non slava da parte di tedeschi, ustàscia croati, italiani e cetnici serbi; la Croazia degli ustàscia compie eccidi anche sui serbi e crea campi di concentramento.
Mentre il bolscevismo diventa una minaccia concreta in tutta la zona, la Germania nazista nel ’41 invade la Jugoslavia e la Grecia e assieme alla Romania da inizio all’attacco diretto in terra sovietica. L’Italia fascista, che aspira ad imporsi nell’Adriatico e quindi nei Balcani, aveva già occupato parti della Dalmazia, della Slovenia e della Grecia, reso l’Albania economicamente dipendente e, dal ’39, colonia italiana; instaura anche un protettorato in Montenegro nel ’41. Ma ancora prima l’Italia sotto l’autorità fascista istituisce una collaborazione con i cetnici bosniaci, croati e montenegrini – scrive lo storico Eric Gobetti in Alleati del nemico – interessati ad una pulizia etnica delle zone considerate serbe
«Si tratta di bande fatte affluire appositamente dalla Bosnia e dall’Erzegovina orientale, oltre che dal Montenegro…Nel corso di due anni e mezzo di occupazione le fonti italiane segnalano uno stillicidio di violenze contro civili inermi… I cetnici agiscono rapidamente…il loro unico scopo è distruggere, saccheggiare e uccidere per rendere inabitabile una data zona. Identificano il nemico essenzialmente nella popolazione di religione musulmana…La documentazione esistente dimostra come le autorità occupazionali abbiano, almeno in due casi, ufficialmente autorizzato i massacri» (Gobetti, 2021:123-125).
Nel ’42 mentre la popolazione musulmana in Bosnia viene massacrata dai nazionalisti serbi cetnici, decide di migliaia di civili croati e sloveni di qualunque sesso ed età vengono evacuati e internati in condizioni disumane e lasciati morire in campi di prigionia, primo fra tutti quello dell’ isola croata di Arbe, a seguito delle direttive del generale italiano Roatta, mentre i nazisti pretendono il trasferimento degli ebrei in Germania. (È da ricordare che questi e altri ufficiali italiani come Robotti, Pirzio Biroli, non furono mai condannati per i crimini di guerra nei Balcani.) Precisa Gobetti (ivi: 131): «Al momento dell’armistizio ad Arbe sono giunti 3577 ebrei, ma sono almeno 5000 gli ebrei salvati dalle autorità italiane in Jugoslavia», forse anche per strategie di realismo politico. Il successivo cambiamento di fronte dell’Italia portò alle estreme conseguenze gli scontrini tra partigiani. La vittoria comunista nei territori jugoslavi abitati da italiani fu conseguenza della tragedia immane, in tempo di pace, dell’esodo forzato di circa 300 mila italiani dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, con i campi profughi e la perdita di tutto, cui seguirono vendette e rese dei conti dei titini anche verso i civili. La maggior parte delle stragi però – secondo la storiografia recente – fu diretta verso collaborazionisti e non comunisti, non si trattò di una pulizia etnica. con i campi profughi e la perdita di tutto, cui seguirono vendette e rese dei conti dei titini anche verso i civili. La maggior parte delle stragi però – secondo la storiografia recente – fu diretta verso collaborazionisti e non comunisti, non si trattò di una pulizia etnica. con i campi profughi e la perdita di tutto, cui seguirono vendette e rese dei conti dei titini anche verso i civili. La maggior parte delle stragi però – secondo la storiografia recente – fu diretta verso collaborazionisti e non comunisti, non si trattò di una pulizia etnica.
Sull’occupazione italiana in Albania
A proposito dell’occupazione in Albania la testimonianza di uno dei generali lì comandato evidenzia l’irrazionalità del rapporto tra il comando militare e il governo centrale a Roma e la gravità della situazione in cui si trovavano i reparti italiani, sovraccaricati da una quantità di compiti . Nella relazione militare In Albania il generale di Divisione Carlo Tucci denuncia i continui dinieghi e i colpevoli silenzi del “Comando Supremo” verso qualunque richiesta gli fosse rivolta: mancanza di artiglierie, di automezzi blindati e di quadrupedi, invio di unità speciali dall’Italia.
«E poiché l’Albania con il Kossovo copre 36.000 km2 ( più che Piemonte e Liguria messi insieme) e vi dilagava la rivolta, non occorrono speciali studi di arte militare per dedurre che le forze di occupazione erano appena sufficienti per assicurare , con perdite , la loro sola esistenza… » (Tucci, 1943: 6).
La relazione descrive anche l’infiltrazione di comandi, uffici e truppe tedesche, che, in breve tempo, presero possesso dei campi di aviazione italiani, dello spazio aereo albanese, del controllo dei porti e di Durazzo. Il tutto con il beneplacito del Comando Supremo mentre – cosa ancora più grave – gli Ufficiali maggiori in Albania non vennero informati dello sviluppo e del cambiamento della situazione politica dell’Italia quale Stato belligerante!
I Balcani ai popoli balcanici?
Parallelamente agli eventi bellici avvengono nei Balcani trasformazioni così radicali da far apparire utopico e del tutto tramontato l’ideale di un balcanismo liberale, che aveva avuto una matrice culturale e ideologica, e un grande scrittore bosniaco, il Nobel Ivo Andrić, portavoce degli ideali panjugoslavi . Lasciando da parte il caso particolare della Grecia, la vittoria comunista ottenuta con le armi diventa realtà in Jugoslavia, Albania, Bulgaria e Romania, i partiti democratici vengono vietati e tutti hanno in comune decenni di terrore e dittature. Soprattutto in Bulgaria e Romania ‒ che non hanno mai avuto solide tradizioni democratiche e dove la fortissima influenza sovietica permea l’esercito ei Servizi segreti ‒ vi sono processi farsa, brogli elettorali, deportazioni.
Nel ’48 le divergenze tra Stalin e Tito creano per alcuni anni un’ulteriore divisione tra gli Stati balcanici. Queste nuove realtà non fanno sparire i perenni conflitti etnici, semmai creano nuovi e drammatici scenari interni con una sistematica persecuzione degli oppositori politici. La successiva vita blindata di questi Paesi coartati su modello sovietico, la guerra in Bosnia dei primi anni ’90 e le tragiche vicende di confine tra Italia e Jugoslavia richiederebbero capitoli a parte. Qui riportiamo soltanto alcune frasi significative del fatto che può cambiare il punto di vista ma sentimenti dolorosi vi furono, ed esistono ancora, sia nei profughi, sia in chi ha scelto di restare. Scrivere in Bora. Istria, il vento dell’esilio Annamaria Mori, esule bambina da Pola nel ’36:
«Non è vero che io e trecentocinquantamila esuli istriani eravamo, eravamo borghesi e fascisti. Non è vero che tutta l’Istria era slava e doveva tornare alla Jugoslavia. Non è vero che tutta la mia gente era nostalgica e irredentista» (2018:15).
Nello stesso libro Nelida Milani Kruljac, anche lei nata a Pola, ma lì rimasta
«Che ne sanno gli esuli del nostro esilio interno? Garantito unicamente dallo spazio casalingo….amarezze da patire, orgoglio da salvare, conflitti da superare e di tensioni, di contraddizioni, di sofferenza e di coraggio» (ivi: 19).
E parla di un «lungo e inutile confine impastato di nuovi afrori coloniali, due tagli tra Slovenia e Croazia… Questo è il nuovo segno speculare della distinzione dell’identità nazionale di questi nuovi Stati» (ivi: 20-21).
Il paradigma di Sarajevo
Oggi la città accoglie un gran numero di turisti. Si va a visitare la Vijećnica, quello che fu Palazzo del Municipio, poi trasformato in biblioteca nazionale durante il socialismo; scrive Eric Gobetti in Sarajevo Rewind
«…la Vijećnica viene colpita da un bombardamento nel 1992 e, nonostante l’intervento di decisioni di cittadini, l’enorme rogo distrugge gran parte dell’immensa raccolta letteraria conservata nel suo ventre ferito…esprime le mille contraddizioni di Sarajevo, di una città che racchiude in sé il mondo intero…Sarajevo, per ragioni sociali, geografiche e psicologiche, è luogo d’incontro di culture differenti…ma anche di scontro» (2016: 124-125).
Assieme ad antichissimi incunaboli di ebrei sefarditi bruciarono testi degli Slavi del Sud e degli europei dei Balcani. Sarajevo è diventata un luogo simbolo. Durante la guerra in Bosnia-Erzegovina, fu sottoposta alla prova durissima dell’assedio più lungo della storia moderna (tre anni e 8 mesi) e gli stati d’animo dei suoi abitanti – ne parla lo storico Duccio Balestracci in Stato d’assedio – sono stati studiati e diventati un paradigma per tutti gli stati ossidionali di ogni luogo «…nel caso del già ricordato assedio di Sarajevo si sviluppa una vera e propria sindrome neuropsichiatrica definita, appunto, sindrome di Sarajevo» (Balestracci, 2021: 143).
Quali prospettive?
L’instabilità dei Paesi balcanici oggi significa anche che si trovano in un limbo. Il loro percorso di adesione all’Unione Europea è ritardato dalla incompleta coincidenza della loro realtà socio-politica e valoriale ai parametri dell’Unione, anche se vi sono specificità di sviluppo economico e si può solo parlare di un mosaico con tanti unicum. L’invasione da parte della Federazione russa dell’Ucraina, che attualmente è solo “candidata”, non può essere valutata con l’unico criterio della definizione dei confini nelle regioni contestate a maggioranza russofona, ma a pesare c’è anche la volontà del Cremlino di annientare il progetto di risposta all’Europa per tutti gli Stati vicini. Non c’è soltanto da fare i conti con la storica interconnessione dell’area con l’ex Urss, ma da tenere presente l’attuale dipendenza dai rifornimenti energetici e dalla fornitura di armi, in misura differente per i vari Stati e la presenza di capitali russi in importanti settori di queste economie. I posizionamenti politici non sono uguali nel corso di questa guerra e potrebbero diventare decisive le scelte politiche di allineamento, con nuove e pericolose prospettive di instabilità della zona.
Dialoghi Mediterranei , n. 60, marzo 2023
Nota
[1] «Nonostante negli ultimi anni i paesi dei Balcani Occidentali abbiano delineato una nuova strategia basata sull’idea di una precisa “identità balcanica”, ponendosi, nel percorso di integrazione europea, come un’entità compatta capace di portare avanti le proprie istanze in maniera coesa…la regione si compone di realtà diverse tra di loro, sia per grado di sviluppo economico e democratico, sia con riguardo allo stadio che i singoli paesi lavorano all’interno del percorso di adesione all’Unione Europea. Il conflitto russo-ucraino, esercitando sui paesi un diverso impatto economico e sociale, ha rimarcato tali discrepanze, dimostrando quanto in realtà la regione sia composta da voci differenti non sempre in armonia e facendo emergere il dualismo di una regione chiusa all’interno dell’ Europa, ma al di fuori dell’Unione Europea.»
Riferimenti bibliografici
Duccio Balestracci, Stato d’assedio , Soc. ed. Il Mulino, Bologna 2021
Federica Cravero, I braccianti dei vigneti portano nelle Langhe un angolo di Macedonia , La Repubblica Torino 20.1.2023
Giorgio Dell’Arti, Le guerre di Putin , La nave di Teseo editore, Milano 2022
Sabina de Silva, L’impatto della guerra in Ucraina sui Balcani Occidentali, a cura del CeSpi, n.98 giugno 2022
Eric Gobetti, Sarajevo Rewind ( nell’originale Rew ind ) Cent’anni d’Europa , Miraggi Edizioni, Torino 2016
Eric Gobetti, Alleati del nemico. Occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943), Editori Laterza, Bari-Roma 2021
Annamaria Mori, Nelida Milani, Bora. Istria, il vento dell’esilio , Feltrinelli Milano 2018, ebook 2021
Daniele Santoro, I Balcani sono una bomba a orologeria , in Il mare italiano e la guerra , «Limes», 8/2022
Oliver Jens Schmitt, I Balcani nel Novecento. Una storia post imperiale , Ed. il Mulino, Bologna 2021
Carlo Tucci, In Albania nel settembre 1943. L’airone, Roma. Relazione estratta dai documenti annessi all’opera di E. Canevari La guerra italiana-Retroscena della disfatta…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^